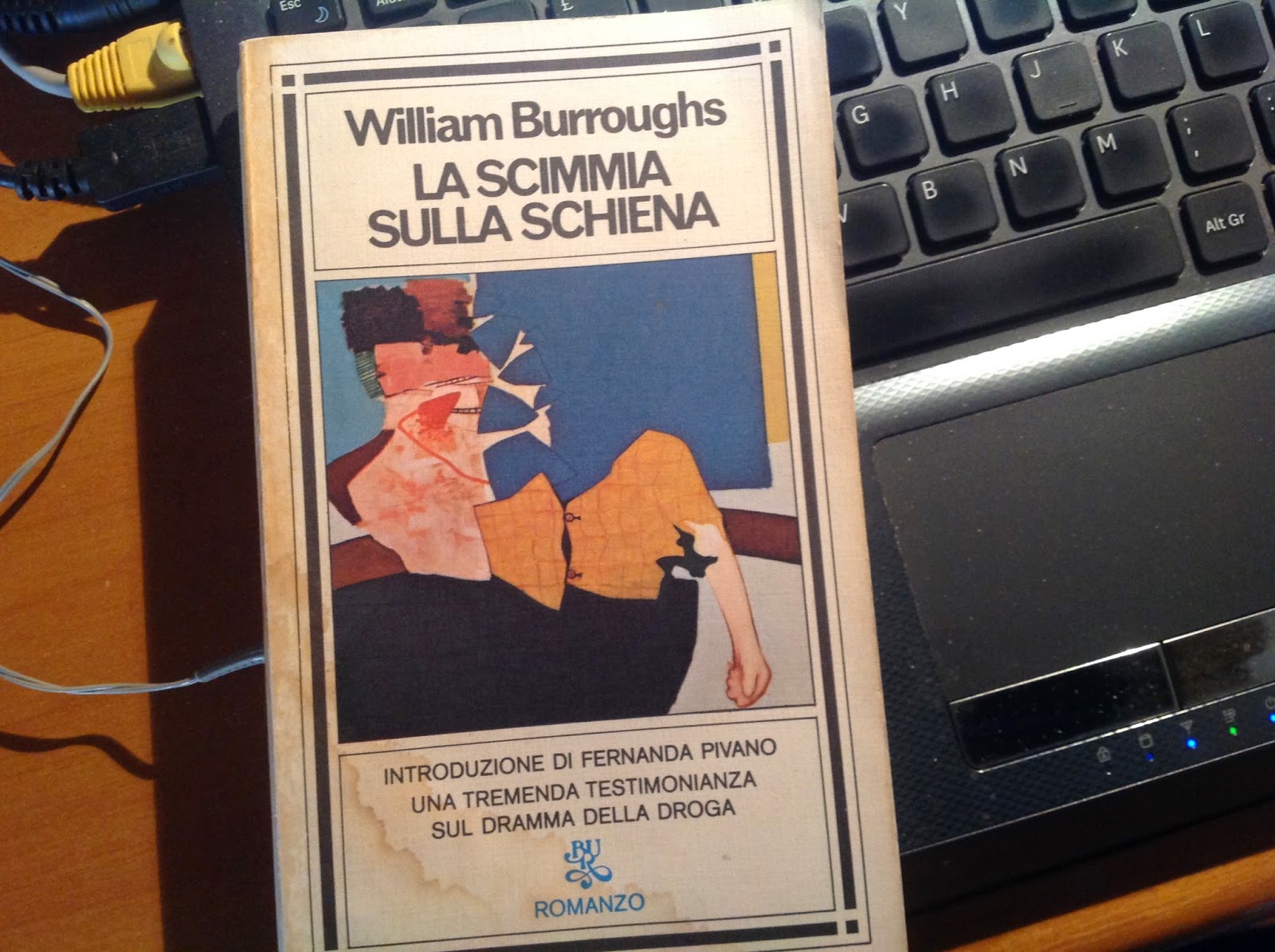L’autrice non è così conosciuta in Italia; di tutta la sua produzione letteraria sono stati tradotti pochi libri, spesso introvabili, come “Gli armadi vuoti” con la traduzione di Romana Petri.
“Non sono più uscita dalla mia notte” è un memoir che racconta l’Alzheimer di cui era affetta la madre e il titolo del romanzo è la frase che l’anziana donna ripeteva nei rari momenti di lucidità.
L’Alzheimer è un’altra di quelle malattie che sconvolgono l’esistenza di una famiglia e che viene vissuta tanto più dolorosamente quanto più si fa fatica ad accettare l’assurdità di certi comportamenti e il degrado, fisico e mentale, nel quale si cade progressivamente
Tutto è capovolto, ora è lei la mia bambina. Ma io non posso essere sua madre
Una frase che è già sufficiente per capire la decisione di mettere la donna in un istituto, insieme ad altre come lei
Qui tutto quello che si perde non si ritrova mai. Indifferenza, tanto stanno tutte per morire
Il libro è infarcito di pensieri, e riflessioni forti in un continuo rimpallo tra il cristiano impulso all’assistenza e l’istinto animale di sopravvivenza che induce ad isolare l’elemento malato, lasciandolo morire.
Parte della decisione sofferta di internarla è frutto di un insoluto tra le due donne
Io sono nata perché mia sorella è morta, l’ho sostituita. Non ho dunque un mio io. Questo argomento sarà presente in un libro successivo: “L’autre fille” del 2011.
L’Alzheimer, come qualsiasi altra forma di disabilità, non riesce a distruggere tutto. Alcuni ricordi rimangono congelati in quegli oggetti che ci hanno reso felici durante l’infanzia o che sono associati a bei ricordi
La scatola degli aghi, dei bottoni, il ditale sono le sole cose che conserverò in ricordo di lei
E subito la mia mente è riandata alla camera dei miei genitori e all’armadio dove, dentro uno dei cassetti erano conservati centinaia di bottoni di tutte le forme, colori, dimensioni con i quali giocavo per ore quando ero ammalata.
Assolutamente struggente l’ultima immagine della madre, ormai in uno stato avanzato della malattia
Quando mi chino per controllare la leva d’arresto della sedia, lei si china a sua volta e mi da un bacio sui capelli.
Un gesto materno che sopravvive nonostante la devastazione mentale e che lascia il dubbio se non ci siano comunque spiragli di coscienza che renderebbero tragico questo cammino lento verso la morte.