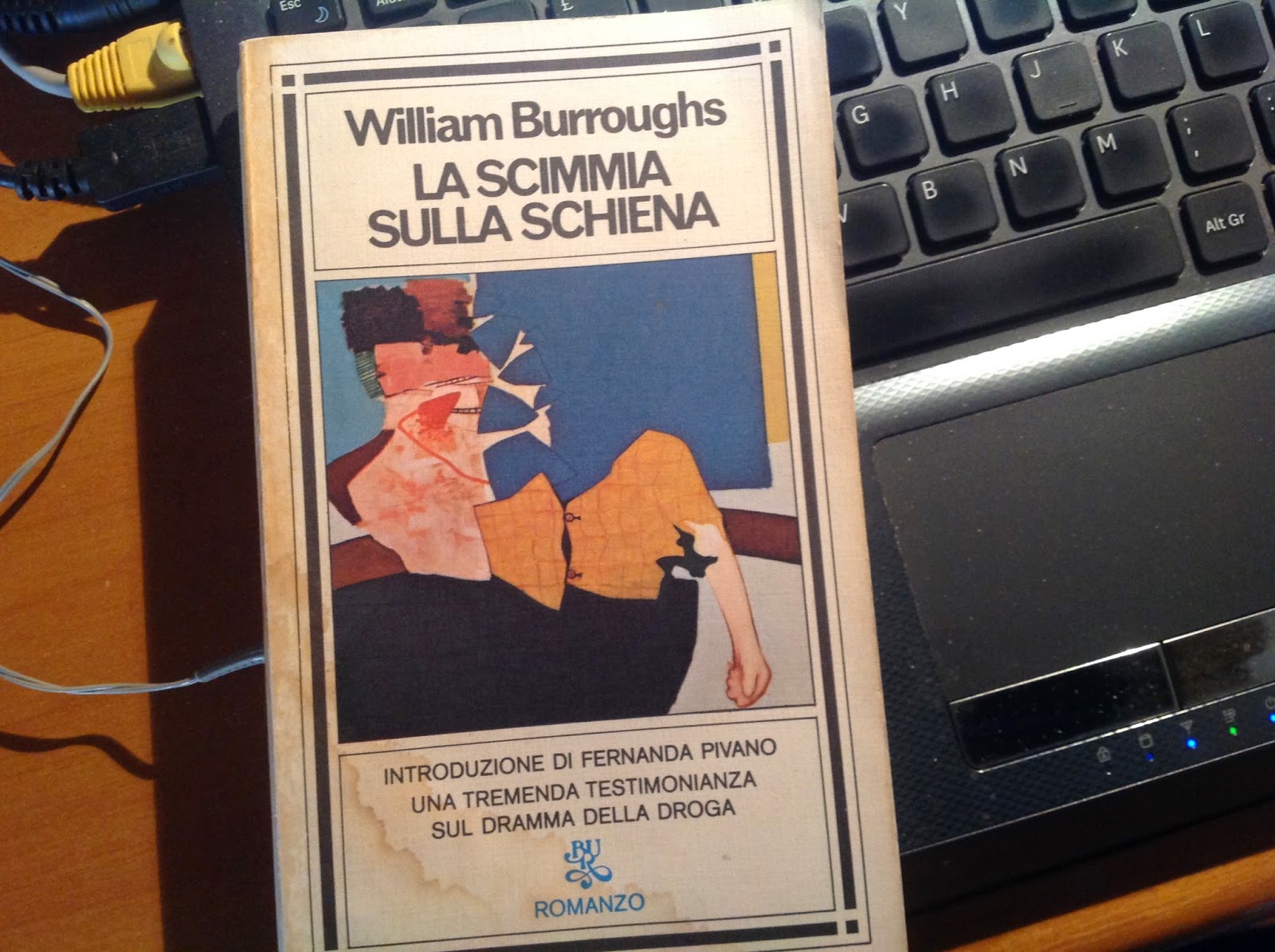Perché ho deciso di scrivere questo libro? È una delle
domande che ricorre con più frequenza nelle interviste. Effettivamente ventidue
anni sono un tempo lungo per una gestazione letteraria, ma era sorta l’urgenza
di narrare dove eravamo partite - mia figlia ed io - e dove eravamo arrivate,
soprattutto dopo la sua esibizione a Londra, davanti a 500 persone, unica
italiana invitata ad un evento internazionale che raduna persone autistiche
dotate di talento. È difficile immaginare che solo venti anni prima le fosse
stata predetta una vita sufficientemente dignitosa.
Quel «Chissà se parlerà…», «Chissà se camminerà…», «È il
caso più grave che abbia visto nella mia carriera!» la dice lunga sul futuro
che mi si era prospettato.Non avevo altra certezza che la verità scientifica della plasticità neuronale ossia della enorme capacità vicariante delle cellule nervose, le quali, se opportunamente stimolate, sono in grado di stabilire nuove connessioni sinaptiche che bypassano le zone degenerate. Su questo ho puntato tutte le mie energie fisiche ed economiche. Per me, laureata con il massimo dei voti e con una carriera brillante davanti, era impossibile pensare che mia figlia non mi somigliasse, non avesse la stessa determinazione e non condividesse con me le identiche passioni .
La prima difficoltà è stata quella di trovare un linguaggio comune, un esperanto che potesse essere calzante per entrambe. La persona autistica ha un suo modo di comunicare ed è inutile cercare di imporre le proprie regole. Si ottengono solo atteggiamenti oppositivi che alimentano l’ansia. Ho pensato che l’Arte, proprio per il suo essere Universale, fosse in grado di trasmettere concetti, di stimolare le percezioni, di modulare le risposte emotive. E così è stato.
In questi vent’anni abbiamo visto concerti, mostre, rappresentazioni teatrali, balletti, visitato musei e alcune città d’arte, alla scoperta dei monumenti italiani più importanti, il tutto corredato dal racconto favolistico del periodo storico perché l’autistico non ha il concetto del tempo. Un minuto, un giorno, un mese sono difficili da quantificare e collocare visivamente. La vita ruota attorno al soddisfacimento dei loro desideri. Per Benedetta la giornata è scandita da colazione, pranzo e cena, mentre l’anno è formato da Carnevale, Pasqua, Estate, Halloween e Natale. Non ha ancora scartato l’ultimo regalo che già pensa a cosa indosserà per Carnevale.
Non è facile stare dietro alle ossessioni scatenate dall’ansia, ogni giorno di ogni mese di ogni anno, senza essere risucchiate nel vortice. Diverse volte ho avuto la tentazione di gettare la spugna e andarmene, non sapendo bene dove e come. Nel libro ho voluto raccontare le frustrazioni che un genitore si trova a dover affrontare a partire proprio da quel figlio così bislacco, difettoso, fino ad arrivare al confronto con la società che, occorre ammetterlo, non è per niente inclusiva.
Si impara a vivere una vita di frontiera, relegati, nostro malgrado, al ruolo di paria, senza neanche il privilegio delle vacche sacre!
Ogni giorno è una battaglia contro l’autismo che pone sempre nuove sfide, in forme e modi diversi. Non appena si riesce a superare un ostacolo, ecco che se ne presenta un altro, più difficile del precedente. Un’immagine calzante è quella di Idra di Lerna e ogni genitore è un Ercole, sempre più spompato che, con la forza della disperazione, taglia via sempre più teste: quella dell’autismo, delle psicosi, della schizofrenia, dell’ipocrisia, dell’emarginazione, dei tanti disservizi sociali, delle incompetenze professionali. Senza mai smettere, senza avere il tempo di respirare, senza riuscire a godersi la vita. Quando ci si ferma, lo specchio rimanda un’immagine che si fatica a riconoscere come propria ed allora parte l’ennesima crociata, questa volta per l’autonomia affettiva, per quel dopo-di-noi che ci strappa le viscere, perché siamo consapevoli di lasciare quel nostro bambino per sempre nell’indifferenza più totale. Temiamo, e quasi abbiamo paura a pensarlo, che venga collocato in uno dei tanti cronicari ad aspettare l’ora di colazione, quella del pranzo e della cena mentre seduto sul divano vedrà passare Carnevale, Pasqua, Estate, Halloween e Natale.
“L’orologio di Benedetta” racconta tutto quello che è capitato prima di Londra dando un messaggio di speranza ai tanti genitori che si trovano a dover affrontare una situazione difficile, quasi impossibile. Non bisogna mollare mai e ogni energia deve essere spesa per favorire la realizzazione del proprio figlio. L’autismo non deve fermare questa ricerca. Farlo significa ammettere la diversità.
Sentirsi riconosciuti per un talento o una predisposizione è il primo passo verso la felicità che, come nell’effetto “domino”, si trasmette a tutta la famiglia e alle persone che ruotano intorno a lui. Tutti, nessuno escluso, cercano la felicità, intesa come significato all’esistenza e questa ricerca non è “tutto o niente”, ma TUTTO E NIENTE.